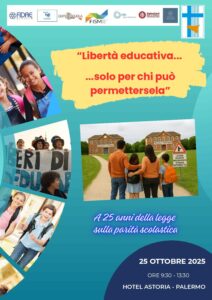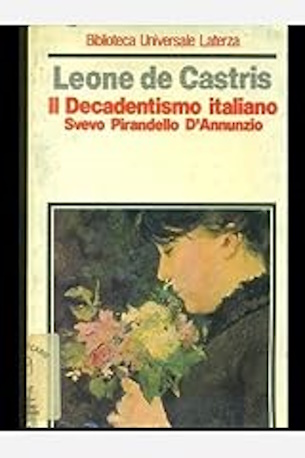
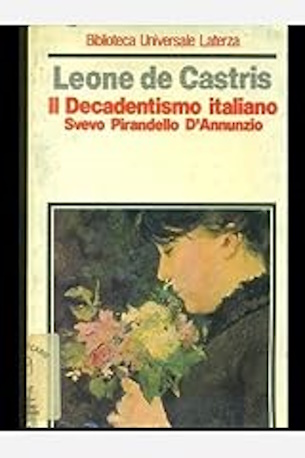 Arcangelo Leone De Castris nel suo volume “Il decadentismo italiano” (Bari, De Donato, 1974) dava un’interessante interpretazione del decadentismo del XX secolo articolandolo nell’analisi di tre scrittori particolarmente indicativi di quel periodo: Svevo, Pirandello e D’Annunzio. Il punto di partenza dell’autore è che la “pur timida rivoluzione industriale” realizzatasi in Italia nel corso degli anni a cavallo tra i due secoli, determinò complesse contraddizioni, nella coscienza degli intellettuali, delle quali una è fondamentale e spiega tutte le altre: quella fra il nuovo ruolo che lo sviluppo capitalistico assegnava alla produzione culturale, la nuova funzione che attribuiva alle attività ideali, e gli strumenti tradizionali del lavoro intellettuale, le vecchie certezze sulle quali gli intellettuali si fondavano. In altri termini, secondo una definizione marxiana, la contraddizione, fra il modo sociale di essere degli intellettuali e la coscienza del loro essere sociale, è rilevante. Il punto di avvio fu, dunque, l’esigenza di una storia sociale degli intellettuali del primo Novecento che cogliesse all’origine la “degradazione di un ruolo sociale” e, insieme, la difesa contro tale degradazione che si manifestava in un atteggiamento ribelle e di opposizione. Esigenza che sorse dalla prospettiva del presente, del periodo storico in cui si viveva, nel quale la massificazione e lo svilimento sociale del lavoro intellettuale si mostrarono in tutta la loro chiarezza, e si muoveva in due direzioni: nella “conoscenza analitica effettiva della cultura del passato, cioè delle forme di una conoscenza parziale della realtà che il lavoro intellettuale produceva entro i rapporti sociali esistenti” e d’altra parte nella coscienza sempre più chiara, proprio perché illuminata dalla storia “ascendente” di tutte le sue articolazioni, del carattere “specificamente produttivo del lavoro intellettuale”, dell’attuale condizione degli intellettuali e della “connessione organica delle opere con la crisi del ruolo”. In tal modo, secondo De Castris, si supererebbero due errori opposti e pur convergenti: “Quello di concepire la materia come trasmissione tutta in se positiva perché autonoma creatività e accreditandola in blocco o comunque recuperandone i contenuti progressivi… senza cogliere il carattere parziale della conoscenza e dunque le ragioni sociali e l’ideologia; e quello di negare indeterminatamente la cultura del passato come espressione diretta della società capitalistica perché totalità mostruosa e priva di contraddizione… sacrificando la dialettica a una visione idealistica della rivoluzione”. Entrambi questi errori sottraggono la produzione letteraria e culturale al suo essere reale, ai significati sociali e ai bisogni politici delle forze produttive, impediscono, di fatto, il passaggio dalla ideologia alla scienza, dalla apologia delle forme creative alla critica delle forme di coscienza, sottraggono il ruolo dell’intellettuale ai rapporti sociali di produzione e confermano nella vita storica o nella morte utopica l’autonomia e la separatezza della funzione della cultura. Partendo da tali premesse viene in primo piano e in nuova luce un dato iniziale, che non era sfuggito ai critici precedenti: il ripiegamento su sé stessi, il favorire i moti interni dell’animo rispetto ai fatti esterni, il monologo interiore rispetto al dialogo, il caricare le cose di valori simbolici che andavano di là della loro dimensione naturalistica, e le parole di significati allusivi, di valori fonici e segreti. È un dato che testimonia un rapporto profondamente mutato tra la cultura e la realtà, fra l’intellettuale-artista e la società: l’uomo insomma non era più un animale politico, ma era rinchiuso in sé stesso, in una solitudine insormontabile, incapace di stabilire una comunicazione con i suoi simili. E l’artista non era più il portavoce dei grandi ideali egualitari del secolo precedente, dell’impegno sociale e politico, della fiducia nella trasformazione profonda della società e del dominio sempre più ampio sulla natura. È così che, per la prima volta, si propose “l’immagine di una realtà disorganica, non razionale e contraddittoria, e di una disorganicità dell’uomo che si identificava in una sua identità come degradata ed indistinta. Divenne una sfasatura del rapporto sintetico-conoscitivo e della stessa volontà comunicativa, egemonica-razionale, del gesto letterario tradizionale.” (by Novecento storie del mio tempo di Riccardo Alfonso)
Arcangelo Leone De Castris nel suo volume “Il decadentismo italiano” (Bari, De Donato, 1974) dava un’interessante interpretazione del decadentismo del XX secolo articolandolo nell’analisi di tre scrittori particolarmente indicativi di quel periodo: Svevo, Pirandello e D’Annunzio. Il punto di partenza dell’autore è che la “pur timida rivoluzione industriale” realizzatasi in Italia nel corso degli anni a cavallo tra i due secoli, determinò complesse contraddizioni, nella coscienza degli intellettuali, delle quali una è fondamentale e spiega tutte le altre: quella fra il nuovo ruolo che lo sviluppo capitalistico assegnava alla produzione culturale, la nuova funzione che attribuiva alle attività ideali, e gli strumenti tradizionali del lavoro intellettuale, le vecchie certezze sulle quali gli intellettuali si fondavano. In altri termini, secondo una definizione marxiana, la contraddizione, fra il modo sociale di essere degli intellettuali e la coscienza del loro essere sociale, è rilevante. Il punto di avvio fu, dunque, l’esigenza di una storia sociale degli intellettuali del primo Novecento che cogliesse all’origine la “degradazione di un ruolo sociale” e, insieme, la difesa contro tale degradazione che si manifestava in un atteggiamento ribelle e di opposizione. Esigenza che sorse dalla prospettiva del presente, del periodo storico in cui si viveva, nel quale la massificazione e lo svilimento sociale del lavoro intellettuale si mostrarono in tutta la loro chiarezza, e si muoveva in due direzioni: nella “conoscenza analitica effettiva della cultura del passato, cioè delle forme di una conoscenza parziale della realtà che il lavoro intellettuale produceva entro i rapporti sociali esistenti” e d’altra parte nella coscienza sempre più chiara, proprio perché illuminata dalla storia “ascendente” di tutte le sue articolazioni, del carattere “specificamente produttivo del lavoro intellettuale”, dell’attuale condizione degli intellettuali e della “connessione organica delle opere con la crisi del ruolo”. In tal modo, secondo De Castris, si supererebbero due errori opposti e pur convergenti: “Quello di concepire la materia come trasmissione tutta in se positiva perché autonoma creatività e accreditandola in blocco o comunque recuperandone i contenuti progressivi… senza cogliere il carattere parziale della conoscenza e dunque le ragioni sociali e l’ideologia; e quello di negare indeterminatamente la cultura del passato come espressione diretta della società capitalistica perché totalità mostruosa e priva di contraddizione… sacrificando la dialettica a una visione idealistica della rivoluzione”. Entrambi questi errori sottraggono la produzione letteraria e culturale al suo essere reale, ai significati sociali e ai bisogni politici delle forze produttive, impediscono, di fatto, il passaggio dalla ideologia alla scienza, dalla apologia delle forme creative alla critica delle forme di coscienza, sottraggono il ruolo dell’intellettuale ai rapporti sociali di produzione e confermano nella vita storica o nella morte utopica l’autonomia e la separatezza della funzione della cultura. Partendo da tali premesse viene in primo piano e in nuova luce un dato iniziale, che non era sfuggito ai critici precedenti: il ripiegamento su sé stessi, il favorire i moti interni dell’animo rispetto ai fatti esterni, il monologo interiore rispetto al dialogo, il caricare le cose di valori simbolici che andavano di là della loro dimensione naturalistica, e le parole di significati allusivi, di valori fonici e segreti. È un dato che testimonia un rapporto profondamente mutato tra la cultura e la realtà, fra l’intellettuale-artista e la società: l’uomo insomma non era più un animale politico, ma era rinchiuso in sé stesso, in una solitudine insormontabile, incapace di stabilire una comunicazione con i suoi simili. E l’artista non era più il portavoce dei grandi ideali egualitari del secolo precedente, dell’impegno sociale e politico, della fiducia nella trasformazione profonda della società e del dominio sempre più ampio sulla natura. È così che, per la prima volta, si propose “l’immagine di una realtà disorganica, non razionale e contraddittoria, e di una disorganicità dell’uomo che si identificava in una sua identità come degradata ed indistinta. Divenne una sfasatura del rapporto sintetico-conoscitivo e della stessa volontà comunicativa, egemonica-razionale, del gesto letterario tradizionale.” (by Novecento storie del mio tempo di Riccardo Alfonso)